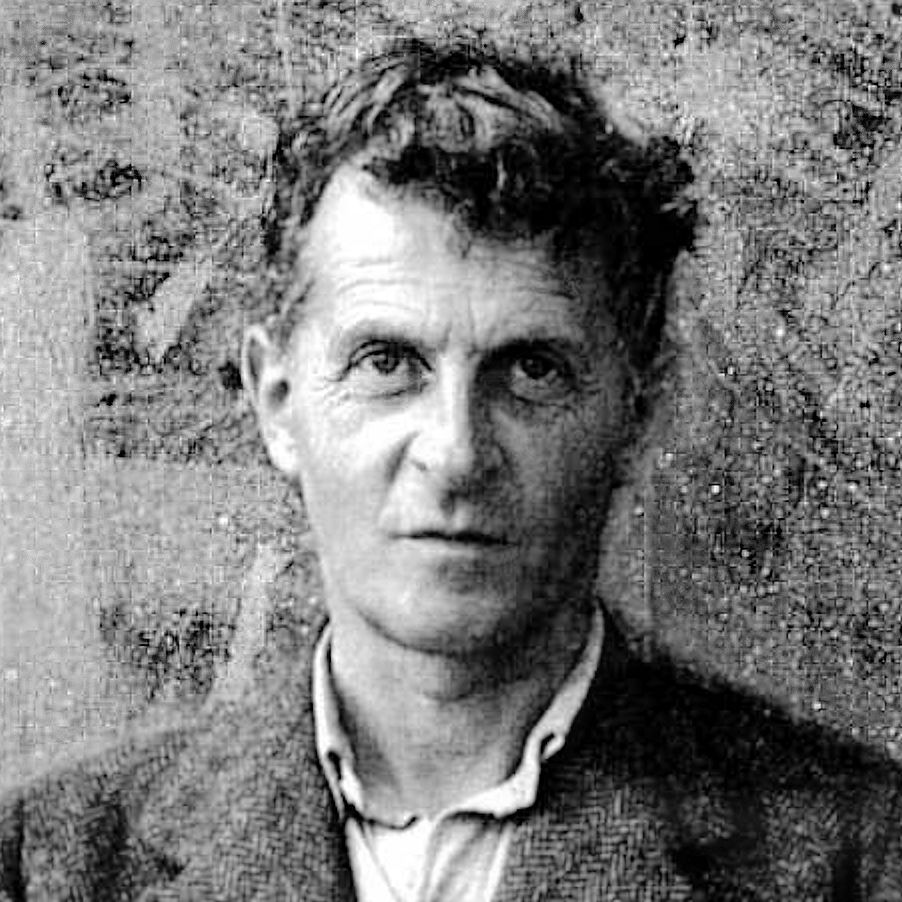Quando si decide di avventurarsi nel complesso e apparentemente inestricabile universo leopardiano, oltre ad attingere al residuo coraggio intellettuale di cui si dispone, si deve obbligatoriamente accettare la condizione di doversi confrontare con l'ostico e al contempo fascinoso concetto di "Pessimismo". Il termine, benché criticamente corretto e diffusamente accettato, è però senz'altro soggetto alla possibilità di una facile travisazione, al rischio cioè di non essere percepito per ciò che, rapportato a Leopardi, effettivamente significa. Se ci concentrassimo esclusivamente sul significato intrinseco e decontestualizzato del termine, converremmo sul fatto che esso venga correntemente utilizzato per indicare la tendenza a ritenere elevata la probabilità che gli eventi futuri siano destinati ad una conclusione negativa. Da qualunque angolazione la si osservi però, una simile interpretazione, pur scolasticamente rigida e rigorosa, non può che risultare superficiale e dunque filosoficamente inadatta ai fini di un'adeguata valutazione del pensiero del recanatese; se così fosse, infatti, le sue teorizzazioni si ridurrebbero banalmente ad una pura e semplice tendenza al negativo. Fossilizzarsi su tale lettura però, non sarebbe soltanto riduttivo, sarebbe clamorosamente sbagliato, e non ci consentirebbe una corretta e lucida valutazione della filosofia leopardiana. Per scavalcare l'idea, sarebbe in realtà sufficiente ricordare che mai Leopardi, filosofo prim'ancora che poeta, ricorse al termine "pessimismo" in riferimento al proprio pensiero, né del resto ciò sarebbe stato possibile. Ed il punto focale di una dissertazione intorno all'opportunità dell'utilizzo di tale termine in riferimento alle straordinarie elucubrazioni di Leopardi, consiste proprio nello stabilire anzitutto cosa lui pensasse del proprio pensiero; del resto, sarebbe ottuso ritenere che la concezione che egli stesso possedeva del proprio intelletto debba piegarsi alle esigenze della critica anziché viceversa. Delle proprie costruzioni filosofiche egli non avrebbe neppure lontanamente potuto concepire la definizione di "pessimismo", in quanto ciò sarebbe equivalso ad accettarne un'intrinseca soggettività, peraltro condizionata e limitante se consideriamo la costante pretesa di universalità del pensiero stesso. Così come lo concepiamo correntemente, il concetto indica fondamentalmente la convinzione di un'ipotetica posteriorità negativa, che mal si sposa con un pensiero assolutamente sentenziante come quello di Leopardi che, dal canto suo, sentenzia. Sentenzia sempre. A ben guardare, il suo pensiero si sorregge per certi versi proprio in virtù della stessa costante ricerca di universalità, ed è da escludere che egli potesse avere percezione di se stesso come pessimista poiché, contrariamente a quanto si possa pensare, fin da giovane non aveva esitato a mostrare una piena consapevolezza della grandezza del proprio ingegno. Pur provandoci, non sono mai riuscito a immedesimarmi in Leopardi, tuttavia lo conosco a sufficienza per sapere quanto pretendesse da se stesso, e se è vero che l'aspettativa tradisce consapevolezza, allora non possiamo negare di trovarci di fronte ad uno degli individui più consapevoli di cui si possa avere memoria.
I Canti sono sublimi, ma Leopardi è più grande nella prosa che nei versi, e di fronte alla straordinaria lungimiranza delle Operette Morali non posso fare a meno di chinare la testa, e chiunque sia dotato di buonsenso dovrebbe fare altrettanto. Quest'opera non finirà mai di sorprendermi, ma ciò che ricavo dal suo studio è la netta convinzione che Leopardi sia definibile in molti modi, ma sicuramente non come pessimista nell'accezione corrente del termine. Se è vero che per lui il passato costituiva uno strumento imprescindibile per la comprensione del proprio presente, un termine di paragone impietoso per giudicare la società umana, è altrettanto vero che ogni sua valutazione, per quanto proiettata verso il futuro, dovesse ai suoi occhi apparire come un lucido e concretissimo "Realismo". Non va infatti dimenticato che Leopardi fu un osservatore del presente, del suo presente, straordinariamente attento e acuto e quindi, ogni accusa di "tendere al negativo" come naturale inclinazione di spirito, non potrebbe che sminuire semplicisticamente quella valutazione critica di una contemporaneità, secondo lui inesorabilmente destinata a involvere in maniera razionale e quasi matematica. Il presente e il futuro dovevano apparire agli occhi di Leopardi in strettissimo contatto, quasi in un rapporto di causa-effetto ineludibile e impossibile da superare. Lo sguardo che Leopardi volge al presente di una società a lui contemporanea, ma paradossalmente da lui separata da una distanza incolmabile ( e il caos intellettuale dello Zibaldone ce lo dimostra inequivocabilmente ), è lucidamente scisso da un'esperienza di vita che, al contrario, tendenzialmente dovrebbe influenzare anche il più attento osservatore. In altri termini, sebbene sia innegabile che l'esperienza condizioni l'individuo, in Leopardi il dramma umano concorre a plasmare il suo "modus cogitandi", ma non il suo punto di vista; egli infatti, pur elaborando filosoficamente in virtù dell'esperienza, acquisendo peraltro una capacità di analisi assolutamente fuori norma, non risulta mai e poi mai condizionato nel pensiero giudicante dal proprio vissuto; l'esperienza conferisce sensibilità e illimitatezza all'ingegno di Leopardi, senza che esso però subisca quell'influenza che normalmente, a causa di uno o più contraccolpi psicologici, condurrebbe a quella già citata tendenza al negativo che al recanatese non appartiene, né apparterrà mai. Si assiste dunque a una scissione tra ciò che Leopardi è e ciò che Leopardi pensa, tra un "io corporeo" è un "io pensante" che, proprio in virtù di tale dualismo, conferisce di diritto pretesa di onniscienza alle teorizzazioni leopardiane. L'onniscienza in questione, però, si configura qui come una reale e concreta capacità di elevarsi sulla realtà e giudicarla, proprio in virtù della scissione, da una posizione del tutto privilegiata.
Come accennato, l'esperienza in Leopardi interviene immediatamente sulla sua capacità di erigere costruzioni mentali, ma non su quello che effettivamente è il suo pensiero. Se una scissione è una divisione, allora Leopardi risulta da subito diviso da una "alterità" e del resto, vivendo una giovinezza dedita allo studio "matto e disperatissimo", a causa di un vissuto castrante e limitante, si divide fin da subito da quella realtà che lui, soltanto più tardi, proprio in virtù di questa iniziale divisione da essa, riuscirà a giudicare con maniacale meticolosità e lucidissima imparzialità. Le pareti della biblioteca tanto maniacalmente allestita dal mediocre Monaldo, i limitanti confini del "carcere recanatese", scavano un primo profondissimo solco tra il filosofo e tutto ciò che è altro, e i fratelli, oltre ai genitori, divengono i suoi unici interlocutori, i quali però, vivendo entro il medesimo angusto contesto, non possono che risultare uno sbiadito riflesso di ciò che egli stesso è e percepisce di essere. Essi infatti non possono né mai potranno porsi come "alterità", semmai soltanto come comparse sgambettanti all'interno di un palcoscenico che in quel momento è anche e soprattutto quello di Leopardi. La biblioteca nella quale trascorre interminabili giornate di studio diviene per lui, quasi paradossalmente, il luogo deputato all'evasione intellettuale, il primo microcosmo nel quale rifugiarsi entro una solitudine che, di fatto, diverrà presto un elemento imprescindibile nella sua ricerca di universalità.
Tale fittizio universo costituisce, di fatto, la prima scissione tra Leopardi e ciò che pare adeguato definire "altro da lui", ed è peraltro una scissione che non ho mai faticato a ritenere consapevole. Che sia consapevole, anche se non volontaria infatti, lo si evince piuttosto nitidamente dallo smodato zelo con cui, anima e corpo, si dedica ad uno studio che, per quanto vivamente caldeggiato, non può dirsi effettivamente imposto, poiché, se così fosse, risulterebbe inspiegabile quell'onnivoro desiderio di sapere che caratterizzerà sempre il genio recanatese, e che lo porterà a profondere uno sforzo fisico oltre che intellettuale sulle ben note "sudate carte"; al contempo però, tale inusitata bramosia, lo renderà consapevole di una diversità di pensiero che quindi, a conti fatti, risulta vera e propria concausa della scissione in questione. La frattura fra Leopardi e tutto ciò che, a tutti gli effetti, è un "non io", non è da intendersi ingenuamente però, si badi bene, come una frattura fra lui, rigidamente ateo, e la Natura onnipotente; quest'ultima infatti, campo di ricerca privilegiato di tutte le ricerche leopardiane, severa interlocutrice dell'islandese delle Operette, è qui ancora lontana dal configurarsi come oggetto d'analisi. Inizialmente infatti, questa "alterità" esterna a Leopardi è semplicemente qualcosa d'altro, qualcosa che si colloca palesemente al di fuori, e che si oppone ad un "io" consapevole in un rigoroso sistema dialettico in cui "io" e "non io" si oppongono, portando il primo ad esclude il secondo nello stesso istante in cui lo contempla. Leopardi, la cui enormità non è ancora sta del tutto compresa, non considera la realtà a lui esterna come un elemento partecipante, ma al contrario, soltanto come un elemento "al di fuori" che, proprio in virtù di tale estraneità con l'io pensante, ne afferma la solidissima consistenza. Va però puntualizzato che il processo mentale in questione si realizza non tanto come opposizione della "alterità", quanto come opposizione alla "alterità". In altri termini, non è il "non io" ad opporsi al già menzionato "io", quanto piuttosto il contrario. Leopardi infatti scinde se stesso percependosi come diverso, fors'anche come escluso, in quanto tale diversità diviene il primo elemento attraverso cui egli riesce ad affermare se stesso in una realtà nella quale, altrimenti, sarebbe impossibilitato ad imporre la propria essenza. La presa di coscienza di una diversità apre in Leopardi un fondamentale squarcio su quello che è il suo reale ed effettivo "io"; egli infatti non è ne sarà mai "parte di", ma sempre è soltanto "sustanza" di se stesso.
Matteo Andriola