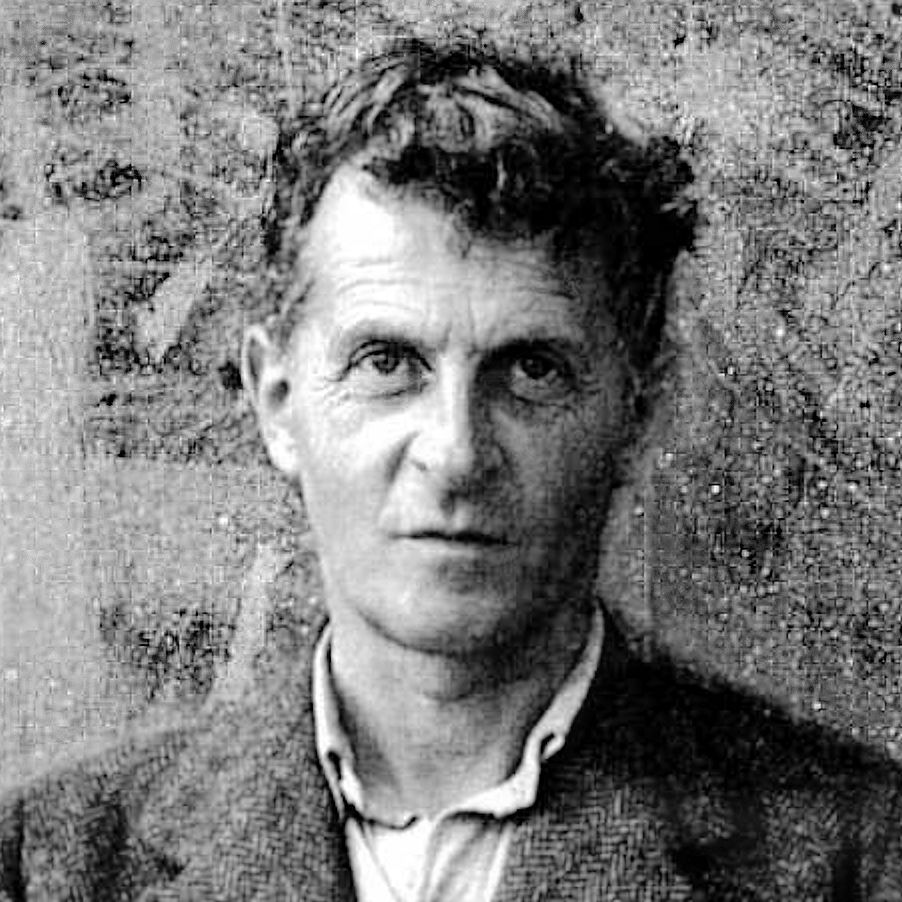Seppur con le dovute cautele del caso, il dibattito relativo alla natura del potere spirituale è quanto mai vivo e attuale. In un'epoca come la nostra, preoccupantemente monca di teorie politiche, la questione stuzzica il mio interesse e, senza nascondere le mie perplessità per una figura, quella del pontefice, che ritengo anacronistica almeno nella forma, trovo incredibile che, pur modificandosi nel tempo, il dibattito relativo al rapporto fra potere temporale e potere spirituale abbia mantenuto inalterata la propria vitalità. Soltanto un ottuso potrebbe sostenere che la società sia effettivamente laica, e nella fattispecie, la figura del papa ha consolidato nel corso dei secoli la propria connotazione politica, e in questo senso, con i caratteri che il ruolo stava assumendo, fu molto più coerente Bonifacio VIII di quanto non lo sia stato il casto e puro Celestino V, costretto a gettare la spugna di fronte all'impossibilità di rendere puro un potere oramai vittima di se stesso e dell'imperante corruzione. Ancora oggi, come detto, la querelle relativa agli eventuali limiti del potere spirituale è percepita come straordinariamente attuale, soprattutto in una società che professa laicità senza crederci veramente. Sostengo la laicità dello Stato, ma più mi guardo attorno e meno la scorgo, e per quanto lo si voglia negare, forse oggi più di ieri, il pontefice è un alleato cui pochi si sentono di rinunciare.
Come spesso mi accade, per comprendere il Presente, certo di non sbagliare, attingo al Medioevo, culla naturale di una disputa che ieri toglieva il sonno a Dante Alighieri e che oggi, seppur in maniera diversa, mantiene inalterata la propria vigoria. Due pensatori hanno affrontato la questione con una veemenza che, quasi contraddittoriamente, trova un'incredibile modernità nella propria essenza profondamente Medioevale: Marsilio da Padova e Guglielmo di Ockham. Marsilio decide di incamminarsi su un sentiero piuttosto impervio, ponendosi l'obiettivo di far crollare la pretesa assolutistica di un papato che agli occhi di molti aveva perso notevolmente prestigio. Parallelamente, Ockham contempla addirittura, in maniera certo clamorosa, la possibilità di un papa eretico, giustificando un'eventuale resistenza nei suoi confronti da parte dei fedeli. Secondo Marsilio, la società è il frutto del desiderio insito in qualunque individuo di condurre un'esistenza che meriti essere effettivamente vissuta; dal canto suo, Ockham assume una posizione destinata a suscitare non meno scalpore, sostenendo la possibilità che il potere temporale prevarichi quello spirituale, riconoscendo a un sovrano temporale la possibilità di deporre un pontefice che non si mostri ossequioso verso le Scritture. Contrariamente ad alcune correnti di pensiero che auspicavano l'unione dei due poteri, Ockham, tanto cauto quanto lungimirante, si mostra invece accanito sostenitore della loro divisione, utile a suo giudizio per preservare una sorta di equilibrio bipolare.
I due filosofi, in un moderno quanto sorprendente slancio di inconsueto sapore democratico, sono concordi nel ritenere il popolo quale depositario del potere, ed entrambi accettano il rischio di sostenere una tesi che inevitabilmente avrebbe finito per scontrarsi contro un potere, quello del papa, mai troppo incline ad accettare di essere messo in discussione. A mio giudizio, anche in relazione al tempo in cui vive, Marsilio, individuando la società quale risultato dell'opportunismo dei singoli, è di una modernità sconvolgente nel ritenere che gli uomini si associno soltanto per andare oltre la mera sopravvivenza, tentando così di realizzare appieno le proprie potenzialità. Le contese, di esempi il Medioevo ne offre molti, dominano la società e la pace può essere garantita solo a patto di impedire che ognuno persegua il proprio vantaggio. Solamente le leggi e un "guardiano" in grado di imporle e vigilare sulla loro pedissequa applicazione, possono garantire la sopravvivenza di uno Stato e tali norme, a suo giudizio ritrovano la propria essenza nell'essere imposte con la forza da chi ne ha l'autorità. La loro validità dunque, secondo Marsilio, non dipende da una qualsivoglia subordinazione a un'entità superiore, quanto piuttosto dall'esclusivo fatto di essere emanate correttamente. Chi conosce il Medioevo sa bene che gli slanci democratici erano merce rarissima al tempo, e per questo, che due pensatori concordino nel conferire ai cittadini una responsabilità legislativa, è da considerarsi un fenomeno straordinariamente all'avanguardia. Sia Marsilio che Ockham, infatti, sono in perfetta sintonia nel riconoscere ai cittadini il delicato compito di entrare nel meccanismo legislativo, e laddove il primo sostiene che i sudditi debbano stabilire le normative in grado di regolare la vita della comunità, il secondo, individuando negli uomini il tramite tra Dio e il potere dello Stato, attribuisce ai cittadini la facoltà di assegnare il potere. Anche se Ockham, ritornando parzialmente suoi propri passi, in casi eccezionali contempla la possibilità che il papa destituisca un sovrano temporale divenuto pericoloso, i due pensatori, troppo acuti per cadere in errore, non faticano a riconoscere nel papato una subdola macchina politica e tentano encomiabilmente di riportarlo entro i ranghi attraverso le proprie teorizzazioni. Marsilio infatti, consapevole del fatto che la Chiesa ricorra troppo spesso a Dio come strumento persuasivo, ridimensiona la forza terrena della legge divina, negando che essa possa risultare vincolante nell'esistenza temporale degli individui; essa infatti, per natura eterna e infallibile, non può né potrà mai possedere nel mondo terreno quella forza coercitiva necessaria per renderla effettivamente valida. Il potere spirituale, che né Marsilio né Ockham negano, può trovare la piena realizzazione soltanto esercitando un ruolo per così dire didattico, educando religiosamente i fedeli in maniera non coercitiva.
Testi come il Defensor pacis e il Dialogus, a conti fatti, non meritano di giacere impolverati dimenticati su uno scaffale, ma il loro contenuto, straordinariamente lungimirante, necessita più che mai di una riscoperta in grado di rinvigorirne freschezza e vitalità.
Matteo Andriola