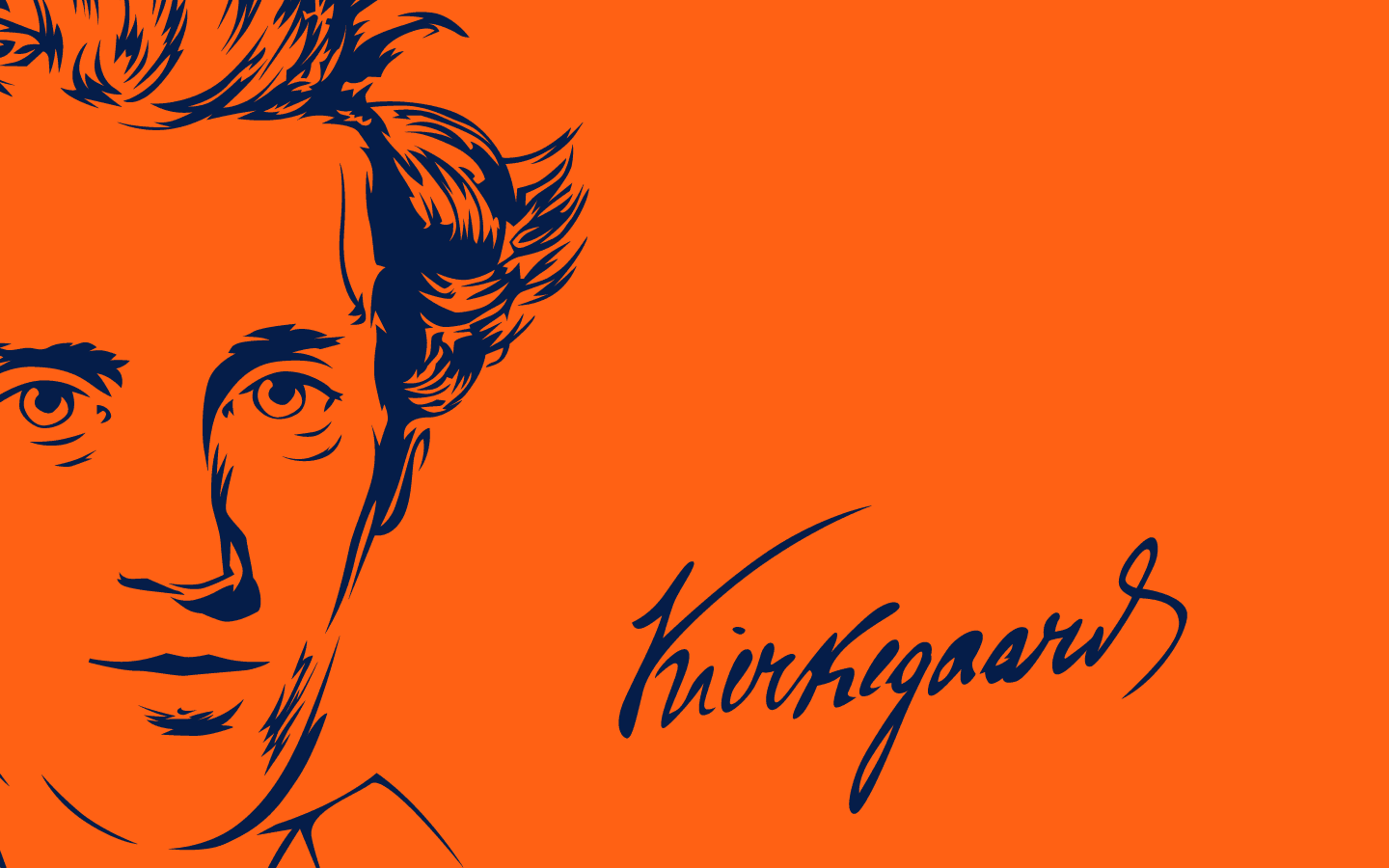Filosoficamente parlando, salire sul carro di Kant è sempre conveniente perchè si può star certi di arrivare a destinazione avendo guadagnato molto più di quanto si possedeva in partenza. Non mi stancherò mai di esaltare l'intelletto straordinario di Immanuel Kant, e al contempo non posso fare a meno di sorprendermi sempre di fronte alla vastità e alla completezza del suo pensiero. Il dibattito circa l'esistenza della divinità è da sempre pane quotidiano per la filosofia, e nel corso della storia ha spesso e volentieri animato confronti accesi ai quali è ancora oggi difficoltoso se non impossibile sottrarsi. Proprio l'illuminismo aveva minato le fondamenta delle teorizzazioni religiose e Kant, che dell'illuminismo è innegabilmente figlio, decise di confrontarsi col problema, come del resto molti suoi contemporanei. Quella dell'esistenza di Dio era questione piuttosto spinosa e appunto dibattuta, e fondamentalmente si reggeva su tre fondamentali e consolidate dimostrazioni filosofiche di esistenza che Kant, pur non intendendo escludere la fede, decise smontare meticolosamente nella sezione della Critica della ragion pura denominata Dialettica trascendentale, sostenendo appunto non tanto l'inesistenza di Dio, quanto l'assoluta impossibilità di provarne scientificamente l'esistenza. In questo senso, il percorso kantiano prende le mosse dalla cosiddetta "prova ontologica" ( teorizzata per la prima volta, come noto, da Anselmo d'Aosta ) che secondo il filosofo risulta limitata in virtù del suo essere erroneamente aprioristica. Infatti, secondo tale dimostrazione, la sola definizione di Dio quale entità perfetta ne implicherebbe l'esistenza senza possibilità di smentita poiché, se mancasse dell'esistenza, all'entità in questione verrebbe meno quella perfezione che invece, a priori, le deve invece essere intrinseca. A parere di Kant però, l'errore fondamentale di tale prova risiede essenzialmente nell'assoluta impossibilità di estrapolare una realtà da un semplice concetto nudo e crudo, e per avvalorare la propria posizione ricorre al celeberrimo esempio monetario, sostenendo che l'acquisizione del concetto di cento talleri, non sia sufficiente per renderli reali e sonanti nelle tasche dei pantaloni di colui che riesce a concepirli concettualmente. La seconda prova con la quale Kant si confronta è quella "cosmologica", che dal canto suo procede in senso inverso ( ossia a posteriori ), sostenendo che la divinità sia necessaria poiché logicamente pretesa dalla contingenza del mondo. Anche questa teorizzazione però, secondo Kant presenta un nervo scoperto facilmente individuabile, consistente specificatamente nel fatto che dimostrare la necessità di un ente non necessariamente ne implica l'effettiva l'esistenza; in altri termini, è possibile teorizzare la necessità di un ente, ma la teorizzazione di fatto non contribuisce in alcun modo a renderlo effettivamente esistente. La terza prova che Kant demolisce, quella "fisico - teleologica", è di fatto la più antica e considerata nella storia della Filosofia, e poggia sulla presunta necessità di un'esistenza ordinatrice, intrinseca al creato. Kant confuta la tesi secondo cui il tutto necessiterebbe di una causa infinita e assolutamente perfetta, sostenendo che l'ordine del tutto sia "relativamente" perfetto, negando dunque che le sue regole possano valere universalmente, in tutti i casi e senza condizioni. Ipotizzare la perfezione assoluta di un'entità creatrice, significa balzare in un sol colpo dal finito della natura all'infinito di Dio. E ciò non è possibile.
L'approccio di Kant al problema generato dalle tre dimostrazioni è in linea con il suo consueto modus operandi filosofico, e se da un lato il taglio empirico dato all'analisi della problematica pare stridere con una questione che dovrebbe a rigor di logica essere affrontata in maniera differente, dall'altro dimostra la straordinaria unicità di un pensatore in grado di sconfinare a piacimento in qualunque territorio filosofico. Chapeau.
Matteo Andriola